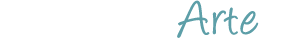Sommario
Quotazioni e valutazioni Anselmo Bucci
| Tipologia opera | Periodo | Quotazioni |
| Dipinti a olio su tela o tavola di grandi dimensioni | Anni Venti/Trenta: gruppo Novecento | Tra gli 8.000 e i 15.000 euro |
| Dipinti a olio su tela o tavola di medie dimensioni | Anni Venti/Trenta: gruppo Novecento | tra i 3.000 e i 6.000 euro |
| Figure o nature morte | Anni Quaranta | 1.000-2.000 euro |
Il periodo più apprezzato della produzione di Anselmo Bucci è quello relativo alla militanza del gruppo Novecento della Margherita Sarfatti: in media le sue opere di questo periodo, se di medie dimensioni sono stimate tra i 3.000 e i 6.000 euro a seconda del soggetto e delle dimensioni.
Picchi tra gli 8.000 e i 15.000 euro per le opere particolarmente grandi e interessanti. Il record d’asta è per una grande tela del periodo di Novecento che è stata aggiudicata a 24.000 euro.
Quotazioni intorno ai 1.000-2.000 euro per le figure o le nature morte della fase più tarda.
Le stime possono subire molteplici oscillazioni per diversi presupposti: il periodo, la dimensione, la qualità, lo stile, la tecnica ecc… Raccomandiamo di contattarci per ottenere una quotazione gratuita e attuale.
Sei aggiornato sui Prezzi di Mercato dei suoi quadri?
La tua opera di Anselmo Bucci sarà valutata gratuitamente dal nostro staff in meno di 24 ore. Carica le foto dell’opera con rispettive misure, della firma ed anche del retro nel form sottostante, oppure utilizza i contatti in alto.
Acquistiamo quadri di questo artista.
Biografia
Anselmo Bucci (Fossombrone, 1887 – Monza, 1955) si trasferisce, da piccolo e insieme alla famiglia, dalle Marche al Veneto. A Venezia viene avviato agli studi classici, ma vista la forte propensione artistica, il padre acconsente a farlo trasferire a Monza per avvicinarlo all’Accademia di Brera.
Frequenta però l’istituzione per un solo anno, poiché rimane molto deluso dall’ambiente forse troppo ristretto dell’accademia. Decide quindi di studiare da autodidatta e di ampliare la sua esperienza di formativa trasferendosi a Parigi, per venire a contatto con la pittura europea.
Parigi
Anselmo Bucci parte alla volta della Francia insieme al pittore calabro Domenico Colao (1881-1943), al veneziano Leonardo Dudreville (1885-1975) e al critico Buggelli. L’artista subisce subito il fascino artistico di Parigi, anzi, nel gruppo di amici, sarà l’unico a stabilirvisi per diverso tempo, superando con tenacia le difficoltà economiche iniziali.
Parigi è la città in cui sceglie di esordire, ventenne, nel 1907, presso il Salon Des Artistes Français. Non pratica soltanto la pittura, ma anche e soprattutto l’incisione, lavorando per diversi editori francesi e, in tal modo, vivendo una vita moderatamente agiata.
La guerra
Nel 1915, all’entrare dell’Italia in guerra, ritorna in patria e si arruola nei Volontari Ciclisti Lombardi. Qui vi incontra Umberto Boccioni (1882-1916) e Antonio Sant’Elia (1888-1916) che moriranno di lì a poco, proprio in guerra, ma anche Filippo Tommaso Marinetti e Achille Funi (1890-1972). Ecco i primi contatti di Anselmo Bucci con il Futurismo, da cui riceve una serie di suggestioni visibili in diverse opere del periodo.
In realtà, però, il pittore non aderirà mai ufficialmente al Futurismo e non firmerà mai neanche un manifesto. Più che altro, risentirà drammaticamente dell’esperienza della guerra, tanto che dedicherà due serie di punte secche proprio alla narrazione della vita in trincea Croquis du front italien e Finis Austriae.
Il ritorno all’ordine
Anselmo Bucci, che fino agli anni Dieci si era fatto interprete di un simbolismo liberty dalla linea irrequieta, negli anni Venti, dopo la guerra approda ad una pittura più tradizionale. Nel 1922, insieme a Dudreville, Funi, Mario Sironi (1885-1961), Ubaldo Oppi (1889-1942), Piero Marussig (1879-1937) e Gian Emilio Malerba (1880-1926), è tra i fondatori di Novecento.
Il gruppo, raccoltosi attorno alle istanze estetiche propugnate da Margherita Sarfatti, elaborava un classicismo moderno, lontano dalle avanguardie e carico di riferimenti all’arte italiana del passato. Anselmo Bucci, pur facendo parte ufficialmente del gruppo, non ne sarà mai un esponente di spicco, perché manterrà sempre una certa autonomia di intenti.
Il suo ritorno all’ordine risveglia soprattutto i canoni dell’impressionismo francese, smorzando un po’ quel carattere severo e rigido di Novecento. In ogni caso espone con il gruppo in tutte le mostre e alle Biennali veneziane.
Il segno Liberty
Rimarrà comunque, nelle immagini di Anselmo Bucci, un leggero riferimento all’arte secessionista e al segno liberty che lo aveva caratterizzato per molti anni, prima della guerra.
Negli anni Trenta inizia a lavorare come illustratore e decoratore di interni. Durante la seconda guerra mondiale, il suo studio di Milano viene bombardato e, gradualmente, tra gli anni Quaranta e Cinquanta si ritira dalle grandi esposizioni come la Biennale.
Ormai l’arte si sta indirizzando verso un informale che non lo coinvolge più, per cui, negli ultimi anni si ritira a Monza, dove muore nel 1955.
Anselmo Bucci: l’acquaforte a Parigi, tra poveri e diseredati
La vera formazione di Anselmo Bucci avviene nelle strade di Parigi, dove si trasferisce all’inizio del Novecento. Sono anni in cui pratica soprattutto il disegno e l’incisione all’acquaforte o a punta secca. Si lega soprattutto a Lorenzo Viani (1882-1936) e frequenta con lui gli ambienti più problematici di una Parigi decadente e maledetta.
Sono di questi anni le incisioni di gusto simbolista e secessionista raccolte in Le petit Paris qui bouge, I vecchi, Giovinezza, Bretagna. Si tratta di incisioni particolarmente tormentate, caratterizzate da un tratto asciutto e suggestivo, proprio dedicato ai più disagiati e umili abitanti di Parigi.
Durante la guerra, cui partecipa da volontario, Anselmo Bucci continua a praticare l’incisione. Nelle raccolte dedicate alla guerra, compaiono incisioni a punta secca come Squadriglia del Garda, Prima dell’assalto, Avamposti, Sentinella, Pattuglie, Prigionieri e La guerra quotidiana.
Ma legandosi ai futuristi proprio in guerra, qualche tela sembra proprio andare nella direzione delle tematiche futuriste e della linea-forza dinamica. Basti pensare a tele come Funerali di un anarchico e In volo.
Il ritorno all’ordine: il dopoguerra e Novecento
Negli anni Venti, Anselmo Bucci decide di abbandonare gradualmente l’incisione. Predilige la pittura, quasi come riscoperta di un classicismo non solo formale, ma anche tecnico. Si fa interprete dunque di una pittura più moderata, tradizionale, che richiama sensazioni impressioniste, ma anche atmosfere palpitanti e dal cromatismo vivace.
Si tratta quindi di un ritorno all’ordine sempre mediato dall’esperienza post impressionista parigina, come si nota dalle tele esposte alla Mostra milanese del 1921, Gli amanti sorpresi, L’Odeon, La madre. Soprattutto nel primo dipinto emerge questo insieme di suggestioni che vanno dal perturbante simbolista alla tradizione italiana nello studio del nudo.
Tagli arditi e modernissimi caratterizzano opere come Lo spasimo, presentato alla Fiorentina Primaverile del 1922. Nello stesso anno, espone alla Biennale veneziana La torre e Il lampo, mentre nel 1924 si tiene una sua personale presso la Galleria Pesaro di Milano.
Forme plastiche e volumetriche
Decisamente novecentista è la tela I pittori, che nelle forme plastiche e volumetriche dei pittori, Anselmo Bucci mette in campo un ritorno all’ordine in piena regola.
Lo stesso avviene nel Ritratto della Signorina Maria Nardi Beltrame, presentato alla Biennale del 1926, che richiama le figure di Antonio Donghi (1897-1963). Nel 1928, sempre alla Biennale, espone il significativo Giuditta che offre reminiscenze classiche e rinascimentali, aggiornate al suo segno personale e moderno.
Questo dipinto, fra l’altro anticipa la serie di nudi cui Bucci si dedica negli anni Trenta, come La modella (Amatori e Cultori di Belle Arti di Roma, 1930).
Continua a partecipare alla Biennale nel 1932 con ben undici dipinti, tra cui i ritratti di Boccioni, Marinetti, Sant’Elia, alcuni paesaggi e dipinti di figura. Importantissima, la sua ultima personale milanese, in cui presenta La Bigia, Signora Angela Legnani, Contessa Ero Cacciaguerra Giungi, Scrittore Rinaldo Kufferle. Partecipa poi alle Quadriennali romani del 1935, del 1939 e del 1943.