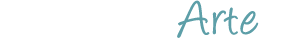Sommario
Quotazioni e valutazioni Felice Casorati
| Tipologia opera | Periodo | Quotazioni |
| Dipinti a olio | Anni Dieci-Cinquanta (dal Simbolismo al ritorno all’ordine al dopoguerra) | da 20.000 a 60.000 euro |
| Tecniche miste su carta | Anni Dieci-Cinquanta | 2.000 – 10.000 euro |
| Incisioni su carta | Anni Dieci-Cinquanta | 500- 1.000 euro |
I dipinti ad olio di Felice Casorati degli anni Dieci, Venti e Trenta (dal Simbolismo al ritorno all’ordine) hanno quotazioni indicative tra i 20.000 e i 60.000 euro a seconda del periodo, dimensione e soggetto. Record dell’artista sono i 621.992 euro raggiunti nel 1999 per un capolavoro del 1918 legato al realismo magico.
Le incisioni su carta hanno una stima media tra i 500 e i 1.000 euro mentre le tecniche miste su carta tra i 2.000 e i 10.000 euro, ma anche oltre per le opere eccezionali.
La carriera di Casorati è stata molto lunga e le stime indicate possono subire oscillazioni per diversi presupposti: il periodo, la dimensione, la qualità, lo stile, la tecnica ecc. Raccomandiamo di contattarci per ottenere una stima gratuita e attuale.
Quanto Vale il tuo Quadro di questo Artista?
Confida sull’esperienza dei nostri esperti per una valutazione gratuita della tua opera di Felice Casorati in meno di 24 ore. Posiziona le foto dell’opera con rispettive misure, della firma ed anche del retro nel form sottostante, oppure utilizza i contatti in alto. Acquistiamo i dipinti di questo pittore.
Biografia
Felice Casorati (Novara, 1883 – Torino, 1963) figlio di un militare, insieme alla famiglia è soggetto a continui spostamenti che lo costringono anche a cambiare diversi istituti scolastici. Studia pianoforte, ma poi lo abbandona per la pittura. Nel frattempo studia giurisprudenza e si laurea nel 1906.
Soltanto un anno dopo, esordisce alla Biennale di Venezia che subito lo rende interessante agli occhi della critica. Vive a Napoli tra il 1908 e il 1911 dedicandosi alacremente a quadri di figura e allo studio della tradizione italiana del Quattrocento.
Dal 1911 al 1915 si trasferisce con la famiglia a Verona, ma la visita alla mostra di Gustav Klimt (1862-1918) a Roma, lo arricchisce di suggestioni secessioniste e simboliste.
Tutta la fase trascorsa in Veneto è caratterizzata dall’influenza Jugendstil e dall’avvicinamento alla Secessione veneziana di Ca’ Pesaro. Si inoltra in intense sperimentazioni simboliste che lo portano ad avere una sala interamente dedicata a lui alla mostra della Secessione romana del 1915. Partecipa alla guerra: richiamato alle armi, dipinge ben poco in questa fase.
Il dopoguerra a Torino
Il dopoguerra è caratterizzato dal ritorno a Torino e dal raggiungimento della maturità artistica di Felice Casorati. Si allontana gradualmente dal linguaggio simbolista per elaborare uno stile pulito e rigoroso, i corpi passano dalla bidimensionalità secessionista ad una forte plasticità.
I contorni si affievoliscono per un recupero delle masse attraverso il colore e il tonalismo costruttivo. Lo spazio risente della Metafisica, ma soprattutto della purezza del Quattrocento. Si fa così protagonista di un ritorno all’ordine tutto incentrato su un intellettuale richiamo al Rinascimento di Mantegna, Antonello da Messina, Piero della Francesca.
Il successo internazionale
Tanti sono i successi di questo periodo, a cominciare dalla personale alla Biennale di Venezia del 1924 introdotta da Lionello Venturi. Molti sono i suoi collezionisti prestigiosi, da Ugo Ojetti a Margherita Sarfatti, alle gallerie americane.
Soltanto alla fine degli anni Venti la sua pittura si fa meno pura e più sfaldata, influenzata dall’espressionismo dei “Sei di Torino”. Continua a procedere per più di vent’anni con grandi composizioni, alternate e piccoli dipinti intimi, a ritratti e nature morte.
Ricompare il segno di contorno, ma le opere rimangono sostanzialmente di impostazione classica, con quella «volumetria astratta» di cui parla Corrado Maltese.
Nel 1941 ottiene la cattedra di pittura all’Accademia Albertina e continua ad insegnare e dipingere per molti anni, accompagnando queste attività a incursioni nell’incisione e nella scultura.
Lavora poi anche come scenografo e costumista teatrale tra gli anni Trenta e Quaranta. Muore a Torino nel 1963.
Felice Casorati: gli esordi secessionisti
Come accennato, Felice Casorati inizia la sua carriera nel segno di un simbolismo secessionista tutto legato a Klimt, Ferdinand Hodler (1853-1918) e Ignacio Zuloaga (1870-1945). Con un “Ritratto” esordisce alla Biennale del 1907, ma è a quella del 1909 che mostra la sua netta adesione al simbolismo.
Espone infatti “Le vecchie e Le figlie dell’attrice“, mentre a quella del 1912 “Signorine e Bambina“. Questo clima dalle forti tendenze grafiche e floreali pervade tutti i soggetti trattati fino allo scoppio della guerra.
“Le ereditiere” compaiono alla Biennale del 1910, “Persone“ all’Esposizione Internazionale di Roma del 1911 e “Il sogno del melograno” alla mostra della Secessione romana del 1913. Bidimensionalità, segno grafico sinuoso e tipicamente Jugendstil compare nelle opere presentate alla Biennale del 1914, “Arcobaleno“, “Via Lattea“ e “Trasfigurazione“.
In questo stupefacente dipinto, tre fanciulle in atteggiamenti diversi si trasfigurano, dopo la morte, in identici corpi segnati da un’inevitabile melanconia.
Opere segnate da una fortissima vicinanza al decorativismo klimtiano, già però intrise della sapienza rinascimentale italiana. Basta notare il vestito della fanciulla ne Il sogno del melograno, citazione della “Primavera“ botticelliana.
Nel 1914 fonda la rivista “Via Lattea” dove sperimenta l’incisione e l’illustrazione che richiama la linea decorativa di Jan Toorop (1858-1928). Il 1915 è l’anno della sua personale alla Secessione romana.
Vi presenta diciannove opere tra cui “Composizione“, “Ricordo“, “Scherzo“, “Papaveri e fiordalisi”, “L’offerta“ e la terracotta verniciata “Maschera rossa“. Di lì a poco la guerra lo allontanerà per un po’ dalla pittura, per poi approdare all’antico.
Il ritorno all’ordine: l’importanza dell’antico
La stagione più fertile per Felice Casorati giunge nel dopoguerra, quando si stabilisce a Torino. Elabora un equilibrio formale puro ed aristocratico in cui si fanno vivi i richiami alla tradizione rinascimentale italiana. Al biennio 1918-19 risalgono alcune opere ancora a metà tra il simbolo e una misteriosa realtà, come “L’attesa”, che risente del tratto nervoso della Secessione.
Poi la linea di contorno si fa meno dura e tutto si concentra su delicati equilibri tonali; studia la prospettiva rinascimentale che riecheggia in continuazione. Al 1921 risalgono “Sorelle“, “Nudo di giovinetta”, “Giovanetta dormiente” e “La donna e l’armatura“.
Non interviene più il simbolismo, ma un neoquattrocentismo equilibrato, una rigorosa classicità silenziosa. Ne sono esempio “Meriggio“, “Madre“, “Ritratto dell’avvocato Gualino”, “Ritratto della sorella”, immagini quasi ieratiche, sospese, rinascimentali.
Basta notare il corpo disteso di Meriggio che richiama il “Cristo morto” di Mantegna nella sua vertiginosa prospettiva. Opere queste, presentate alla Biennale del 1924, dove viene accompagnato da un entusiastico dal testo di Venturi.
Scrive: «Si tratta di far sorgere su dalle forme e dai colori, dalle visioni in profondità e dalle superfici distese, dagli effetti tonali senza chiaroscuro e dalle tinte brillanti, un principio di personalità, un fremito di vita».
Realismo Magico
Felice Casorati può inserirsi nella definizione che Massimo Bontempelli fa del Realismo Magico, in opere che nascondono forti implicazioni inconsce. Ne sono esempio “Beethoven“, “Ospedale“, “Daphne“, presentate nel 1928 a Venezia che sono sì realiste e afferenti al classicismo, ma rivelano quella vaga sensazione di mistero e di irrisolto tipica del Realismo Magico o della Metafisica.
Pur partecipando alle mostre di Novecento di Sarfatti del 1926 e del 1929, non entra a far parte del gruppo. Casorati mantiene sempre un tonalismo puro e rigoroso, per poi passare ad un colore più intenso e ad una linea più libera dagli anni Trenta in poi.
Alla Quadriennale romana del 1931 allestisce una personale, una sorta di sunto della propria carriera fino a quel momento. Un punto di svolta che si riflette poi nella seconda e nella terza Quadriennale in cui presenta nature morte e ritratti di carattere meno rigido che lascia spazio anche ad accenni astratti.